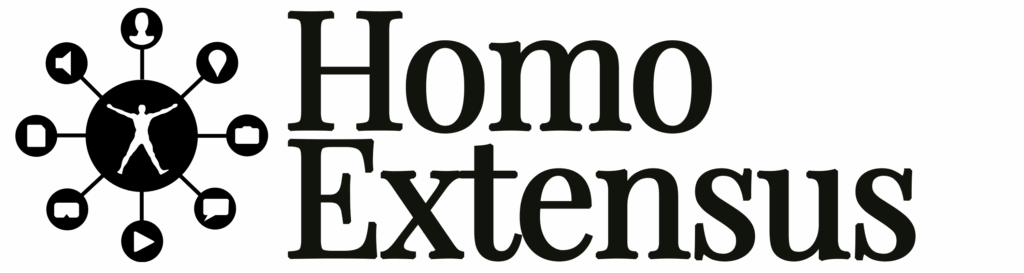Il XX secolo è caratterizzato dall’affermazione dei mass media, che si aggiungono alla stampa con forme di comunicazione più inclusive. Il cinema si afferma in Francia, poi si impone la radio inventata dall’italiano Marconi, e in seguito la TV, sintetizza queste due invenzioni e domina la seconda metà del secolo. Nel 1895 I fratelli Lumière brevettano il Cinématographe, una macchina in grado di mettere in sequenza fotografie in modo da effettuare un effetto animato. Con questa nuova tecnologia registrano dieci film, che lo stesso anno a Parigi proiettano di fronte a un pubblico pagante. La reazione del pubblico fu emblematica: di fronte ad un treno che avanzava, gi spettatori si spaventarono e fuggirono. Questa reazione emotiva indica due proprietà tipiche del cinema: il realismo, derivato dalla fotografia da cui proviene, e la capacità di ingannare, che fu subito sfruttata dal primo esperto in effetti speciali: Georges Méliès. Se quindi da una parte dal cinema possiamo far derivare la televisione, e i telegiornali, che ancora oggi riportano ciò che realmente accade nel mondo, dall’altra nasce una forma di narrazione, ben definita come “fiction”, che non ha la rappresentazione del vero come obiettivo. L’intelligenza artificiale sta dalla parte degli effetti speciali, e infatti è un media sintetico, che non deriva dalle riprese della realtà. I mass media non sono propriamente delle tecnologie cognitive, piuttosto si tratta di mezzi di comunicazione. Tuttavia, come insegna il più classico massmediologo del XX secolo, Marshall Mc Luhan, “il medium è il messaggio” perché è il medium – e non il contenuto – che plasma le dimensioni e le forme della società umana. Dopo essere esploso per tremila anni con mezzi tecnologici frammentari e puramente meccanici, il mondo occidentale è ormai entrato in una fase di implosione: l’elettricità ha ridotto il globo a poco più di un villaggio. Una rapida accelerazione ha ristabilito uno schema tribale di intenso coinvolgimento, con l’avvento della radio e della TV.
Il cinema, in quanto forma non verbale di esperienza, è, come la fotografia, una forma di dichiarazione senza sintassi. Il pubblico cinematografico, come il lettore di libri, accetta come un fatto razionale la sequenza in sé stessa. Dato che deriva dalla sceneggiatura scritta, il cinema è tuttavia immerso in una cultura libresca. Soltanto una cultura alfabetica e astratta impara a tenere gli occhi fissi, come si si deve fare per leggere la pagina stampata. Lo scrittore, in quanto autore delle sceneggiature o dei romanzi di ispirazione, sa di poter raggiungere una profondità che il cinema non riesce ad eguagliare.
La radio è invece un tamburo tribale, che tocca tutti intimamente e personalmente e restringe il mondo alle dimensioni di un villaggio con i relativi pettegolezzi, voci e attacchi personali. Ma le diverse aree di questo mondo radiofonico sono separate dalle lingue. Nella Germania di Hitler la radio è riuscita a ravvivare residui arcaici e antiche memorie, diventando un potente strumento al servizio della dittatura e del nazionalismo. Dal punto di vista semantico la radio può essere descritta come un’estensione del sistema nervoso centrale alla quale può essere accostato solo il discorso umano. Le regioni da tempo alfabetizzate che hanno automaticamente eroso le proprie tradizioni orali, si sono trovate a doverle riscoprire per affrontare l’età elettrica.
In genere i media determinano una amplificazione dei sensi: la radio è una estensione dell’udito, la fotografia della vista. Ma secondo Mc Luhan la TV è soprattutto una estensione del tatto, che implica una intensità di azioni reciproche tra tutti i sensi. Mentre la scrittura fonetica separa e frammenta i sensi per esprimere complessità semantiche con il netto distacco dell’astrazione, le altre scritture ideografiche e i media visivi conservano una ricca orchestrazione dei sensi.
L’immagine televisiva, suscitando un appassionato desiderio di coinvolgimento profondo nell’esperienza dello spettatore, crea l’ossessione del piacere e del benessere fisico, che si traduce nella ricerca dell’intrattenimento. La TV non può essere uno sfondo: ci impegna e ci assorbe.
I grandi eventi televisivi coinvolgono l’intera popolazione in un processo rituale.
Esposto alla TV, il bambino guarda il mondo in modo antitetico rispetto all’alfabetismo.
Nessuno dei mass media del ‘900 ha tuttavia determinato una profonda rivoluzione cognitiva, e infatti nonostante il loro rilevante impatto politico ed economico, cinema e TV sono rimasti al di fuori della scuola e dell’università, dove domina ancora la cultura alfabetica dei libri di testo. Solo in alcuni paesi la radio e la TV sono state adottate per casi sporadici di insegnamento rurale e delle zone più remote.
Ma l’uomo moderno grazie alla TV ha esteso la sua percezione al mondo interno, e la condivide con l’intera umanità, creando un’empatia globale. Di fronte al primo passo sulla luna, o alla caduta delle torri gemelle, trasmesse in diretta mondiale via satellite, l’uomo diventa cittadino globale.